Editoriale
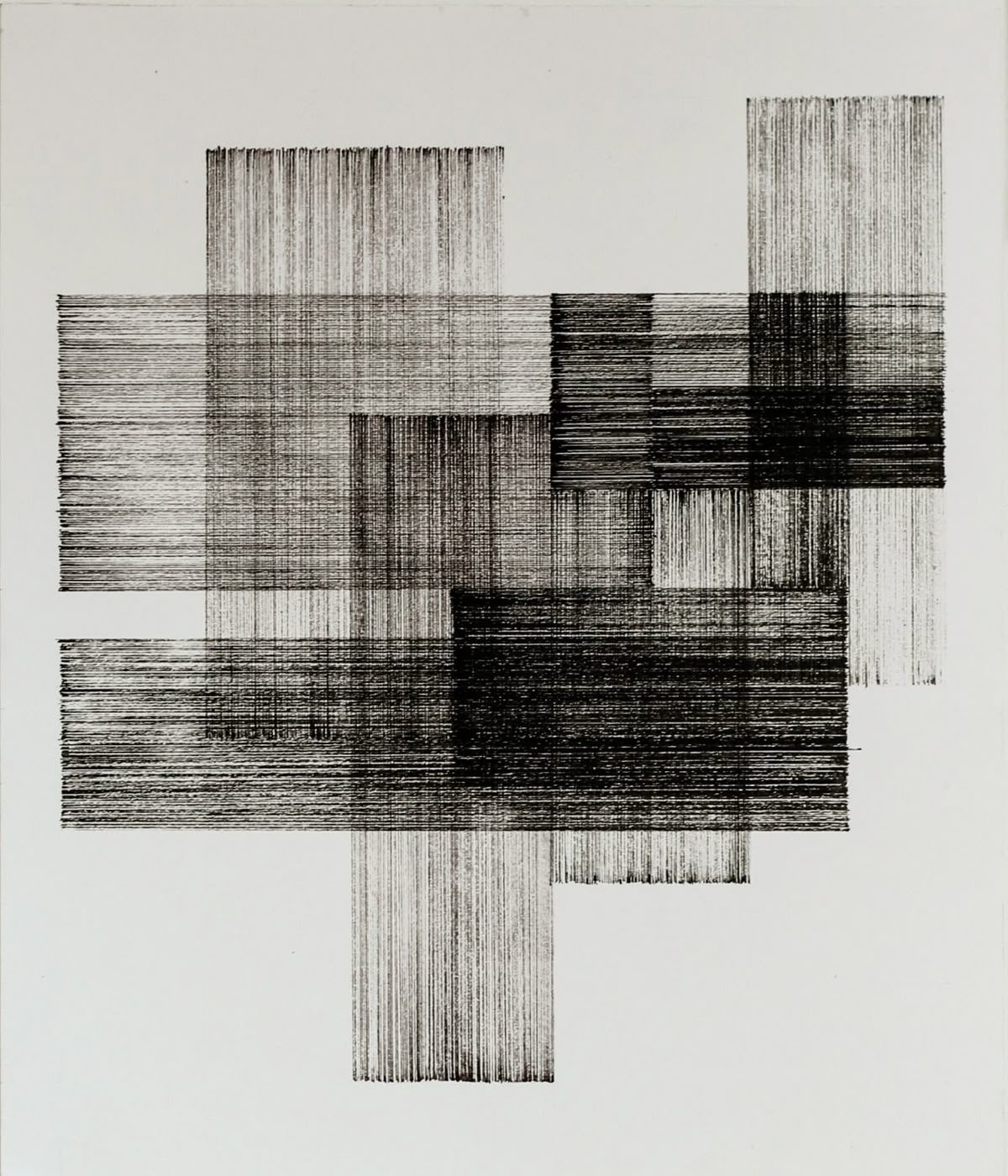
Insieme, tra settembre e ottobre, abbiamo camminato per le strade, abbiamo condiviso rabbia e indignazione, abbiamo bloccato stazioni, tangenziali, aeroporti. Al centro di quello straordinario movimento è stata la Palestina – una Palestina fattasi da tempo “globale”. E tuttavia, quel movimento si sta collocando, non solo in Italia, oltre l’orizzonte della tradizionale solidarietà “internazionalista”. Il genocidio di Gaza, pur nella sua storica e terribile singolarità, è stato assunto come specchio della violenza che segna l’attuale congiuntura, come schermo capace di riflettere tutte le ingiustizie che – secondo una geometria variabile ma interconnessa – dominano il mondo di oggi. La determinazione per porre fine al genocidio, con ogni mezzo necessario, si è dunque coniugata con i linguaggi e le pratiche in cui si esprimono quotidianamente le lotte sociali. È successo in Italia, ma anche in altri Paesi europei, in Tunisia, in America Latina. La potenza e la dimensione globale di questa insorgenza ci sono del resto anche restituite dal vergognoso tentativo di numerosi governi occidentali di smarcarsi dalla complicità con la politica di sterminio in corso a Gaza. Nel giro di qualche settimana abbiamo così avuto una formidabile, e auspicabilmente non effimera, esemplificazione dei caratteri fondamentali di una nuova politica mondiale della liberazione.
È questo l’orizzonte in cui si colloca il numero di Teiko che presentiamo. Il suo obiettivo è offrire un insieme di strumenti per pensare politicamente il mondo in cui viviamo, oltre le retoriche della globalizzazione e della de-globalizzazione. Di fronte a noi non abbiamo certamente processi di lineare unificazione del pianeta, e tuttavia la retorica del “decoupling” e la realtà delle guerre commerciali, le inedite e profonde fratture che stanno segnando l’attuale congiuntura non cancellano affatto la realtà materiale dell’interdipendenza. La crisi del sistema internazionale (ovvero del sistema di relazioni costruito attorno agli Stati nazionali) si intreccia oggi con la crisi altrettanto radicale che investe il “sistema mondo” – ovvero l’organizzazione politica del mercato mondiale così come si era configurata a partire dal protagonismo dei principali attori capitalistici nell’alleanza con potenze territoriali egemoni. In quello che Giovanni Arrighi definiva come caos sistemico è difficile intravedere l’emergere di un nuovo principio d’ordine, pur a noi avverso. Proprio per questo la guerra, combattuta sul terreno o capace di strutturare con le sue logiche economie, sistemi politici e società, si è installata al centro della congiuntura. Questioni antiche, come il rapporto tra guerra e capitale, tra capitalismo e imperialismo, si pongono oggi in modo nuovo.
Da tempo è tramontato il mondo unipolare emerso dopo il crollo del muro di Berlino nel 1989, caratterizzato dall’egemonia globale statunitense e dal regime di accumulazione neoliberale che l’ha accompagnata. Nella turbolenza, nelle tensioni e nei conflitti di fronte a cui ci troviamo dobbiamo essere in grado di cogliere il punto di non ritorno, l’insostenibilità e la saturazione della stessa logica dell’accumulazione capitalistica. Non siamo in presenza di una semplice proliferazione e sommatoria di diversi tipi di crisi, come sembra lasciare intendere il diffuso concetto di “policrisi”. In questione è la stessa razionalità della valorizzazione capitalistica, e cioè una coazione oggettiva a produrre sempre e comunque valore entro una condizione di concorrenza planetaria e multidimensionale, che investe cioè ogni sfera della vita economica, politica e sociale. Questa razionalità non sembra essere oggi in grado di costruire mondi abitabili e di garantire la continuità dell’accumulazione: fa dunque della crisi – e tendenzialmente della guerra – la forma stessa dello sviluppo. Non è necessariamente una buona notizia. Il capitalismo può certo adattarsi a queste condizioni, incrementando il suo potenziale di distruzione via via che emergono linee di scontro a livello mondiale. È bene in ogni caso essere consapevoli della radicalità delle poste in palio nell’attuale congiuntura, in cui la logica dell’egemonia non sembra offrire alcuna prospettiva di ordine.
Non inganni, in questo senso, il bullismo di Trump, lo spettacolo di potenza che ci ha proposto negli scorsi mesi, fino al coronamento con l’accordo di Sharm el-Sheikh: la virulenza autoritaria del suo tentativo di restaurazione sovrana è il sintomo più eloquente della crisi irreversibile dell’egemonia globale degli Stati Uniti. È un processo cominciato da tempo, che ha avuto nelle guerre in Afghanistan e in Iraq e nella crisi finanziaria del 2007/8 i propri apici e le proprie soglie di non ritorno. La distribuzione del potere e della ricchezza su scala planetaria disegna oggi un multipolarismo centrifugo e conflittuale, ponendo le basi per il proliferare di tensioni e di conflitti. Azzardiamo una lettura delle politiche di Trump: guerre commerciali, pressioni, ricatti, dispiegamento della forza verso regioni come quella caraibica e grandi disegni logistico-immobiliari nel Medio Oriente puntano a ritagliare gli spazi per la proiezione della potenza politica ed economica statunitense e a impedire un’ulteriore crisi del dollaro come moneta di riserva globale. È un progetto ambizioso, che non punta tuttavia a ristabilire l’“egemonia” all’interno del sistema mondo e riconosce piuttosto l’esistenza di un insieme di poli relativamente autonomi (la Russia, la Turchia, l’India) nella prospettiva di una competizione strategica con la Cina.
La condizione di questo progetto è il tentativo di determinare a partire dalla posizione di persistente forza degli USA, l’allineamento tra il capitalismo e il suo Stato, ovvero di riaffermare con violenza la denominazione nazionale del capitale statunitense. I processi di concentrazione del capitale, così evidenti in particolare dopo la pandemia da Covid-19 nel settore “Big Tech”, nel nuovo protagonismo della leva finanziaria attraverso i fondi d’investimento e nell’ulteriore accelerazione dell’estrattivismo, dettano il ritmo di questo progetto, mentre le forzature sul piano costituzionale puntano a esaltare il potere esecutivo liberandolo da limiti e controlli. Sotto il profilo delle ricadute interne agli USA, le conseguenze sono evidenti nella vera e propria guerra civile dall’alto condotta dalla seconda amministrazione Trump – contro i migranti, contro l’eredità della stagione dei diritti civili, contro ogni dissidenza politica e culturale. Le forme nuove di autoritarismo e fascismo che così si manifestano entrano in risonanza con precedenti esperienze nel mondo all’interno del ciclo politico che si è aperto con la crisi del 2007/8 e si irradiano, generandone e rafforzandone altre.
Mentre ambisce al Nobel per la pace, Trump pone oggettivamente le condizioni per nuove guerre. Nelle sue politiche interne e internazionali, il violento disciplinamento dei rapporti sociali si combina con i processi di concentrazione del capitale puntando a configurare i diversi poli che esistono nel mondo secondo la logica – per definizione militare – dei blocchi. La guerra si fa dunque atmosferica, assume la forma di un regime di governo e dove già si combatte viene messa a valore economicamente. Il “piano Trump” per Gaza è da questo punto di vista paradigmatico: assume il genocidio come propria condizione di possibilità e punta, sulla base della cancellazione della soggettività politica palestinese, ad attrarre capitali dalla regione in una “zona economica speciale” sospesa tra le operazioni militari a intensità variabile di Israele e le tensioni con potenze come in particolare la Turchia.
Come articolare una prospettiva critica, di ricerca e di azione, all’interno del quadro che abbiamo delineato? Se queste sono le linee di tendenza, occorre in primo luogo individuare i limiti che ne segnano il possibile sviluppo. Vi è in primo luogo da sottolineare la radicalità del passaggio d’epoca che stiamo vivendo. La crisi dell’egemonia globale degli Stati Uniti è al tempo stesso la crisi della centralità dell’Europa e dell’Occidente che ha retto il sistema mondo capitalistico fin dalle sue origini cinquecentesche. Derivano da qui un insieme di formidabili tensioni, a cui si allude nei dibattiti contemporanei guardando alla crescita dei BRICS o del cosiddetto “Sud globale”. È bene intendersi su questo punto: non siamo qui in presenza di alternative di sistema, e anzi molti dei Paesi inclusi in queste formule mostrano tendenze assimilabili a quelle che abbiamo brevemente descritto per gli Stati Uniti – si pensi al militarismo di Putin in Russia, al fondamentalismo indù di Modi in India, allo stesso nazionalismo di Xi Jinping in Cina. Anche nel “Sud globale” quel che conta per noi – contro ogni tentazione “campista” – è la lotta di classe, la capacità di una serie di forze sociali subordinate di rompere sistemi consolidati di dominio e sfruttamento aprendo nuove prospettive per una politica della liberazione. Tuttavia, gli spostamenti di potere e ricchezza su scala globale a cui abbiamo assistito in questi anni pongono oggettivamente dei limiti a una logica di lineare proiezione di potenza e di formazione di blocchi.
Le profonde fratture che segnano il mondo in cui viviamo, è una delle ipotesi attorno a cui è costruito questo numero della rivista, si determinano poi a partire dalla persistente azione di processi globali (ne descriviamo alcuni nella prima sezione). Il gioco di specchi che si è instaurato tra gli Stati Uniti e la Cina (che in una prospettiva liberale assume la forma di un presunto “capitalismo di Stato” e di una logica simile nelle restrizioni commerciali) ne è una buona esemplificazione. Pensare insieme fratture e vettori di unificazione è anzi per noi uno dei compiti fondamentali per delineare una teoria critica della politica e del capitalismo mondiali. Tra gli spazi politici che si organizzano attorno ai grandi Stati e gli spazi disegnati dai movimenti e dalle operazioni del capitale non c’è in ogni caso coincidenza, c’è anzi una tensione strutturale (è il tema a cui sono dedicati i contributi raccolti nella seconda sezione). È un punto importante, perché rende conto della difficoltà di imporre come criterio politico essenziale quella che abbiamo definito la denominazione nazionale del capitale. In altre parole, la stessa dinamicità dello sviluppo capitalistico può essere limitata dalla logica dei blocchi, a detrimento di specifici interessi economici (di specifiche “frazioni di capitale”) e con una esasperazione dei costi e delle contraddizioni sociali. Ci sembra importante aggiungere che, mentre molti osservatori pongono l’accento sul “ritorno dello Stato”, quest’ultimo appare profondamente trasformato dall’azione dei processi globali che si sono richiamati: la “razionalità” della finanza, ma anche quella della logistica, ha contribuito a ridefinire la stessa struttura istituzionale dello Stato, rendendola molto diversa da quella che caratterizzava l’epoca classica dell’imperialismo. La distinzione tra logiche pubbliche e logiche private, in particolare, è stata offuscata da queste trasformazioni, che si sono insinuate nelle stesse macchine militari e nelle dinamiche monetarie. Si pensi anche allo sviluppo delle criptovalute e delle monete digitali come specchio di questo nuova forma di sovranismo.
Si tratta di una circostanza da tenere presente nell’analisi delle tensioni e dei conflitti del nostro presente. Anche sotto questo profilo, la linearità di una proiezione di potenza secondo la logica dei blocchi come criterio di fondo degli sviluppi mondiali – ovvero la linearità di un nuovo imperialismo – appare problematica, senza che questo in alcun modo risulti rassicurante. Certo, ragionando sui limiti che si frappongono alle attuali tendenze alla formazione di blocchi all’incrocio tra concentrazione del capitale e autoritarismo politico e sociale, l’aspetto essenziale per noi è quello da cui siamo partiti, ovvero le lotte e i movimenti che quotidianamente si battono in molte parti del mondo contro quelle tendenze. Nella terza sezione di questo numero della rivista, cominciamo a darne conto. Qui vorremmo indicare qualche principio di metodo per l’analisi di quelle lotte e di quei movimenti nel quadro generale che abbiamo delineato. In questione è la reinvenzione dell’internazionalismo, a cui dedichiamo un corsivo. È evidente che qualsiasi lotta deve essere ricostruita prima di tutto guardando al suo radicamento in specifici contesti, tanto storici quanto territoriali. E tuttavia il nostro compito, tanto dal punto di vista analitico quanto da quello politico, non può essere quello di sommare semplicemente le singole lotte. Siamo piuttosto convinti che un punto di vista fondamentale sia offerto dalle risonanze tra di esse, dagli elementi comuni che emergono in piena luce proprio considerandole dal punto di vista delle fratture e dei vettori di unificazione che compongono la dimensione planetaria. È su questa dimensione che, contro i blocchi e contro ogni forma di imperialismo, una politica della liberazione può prendere forma.
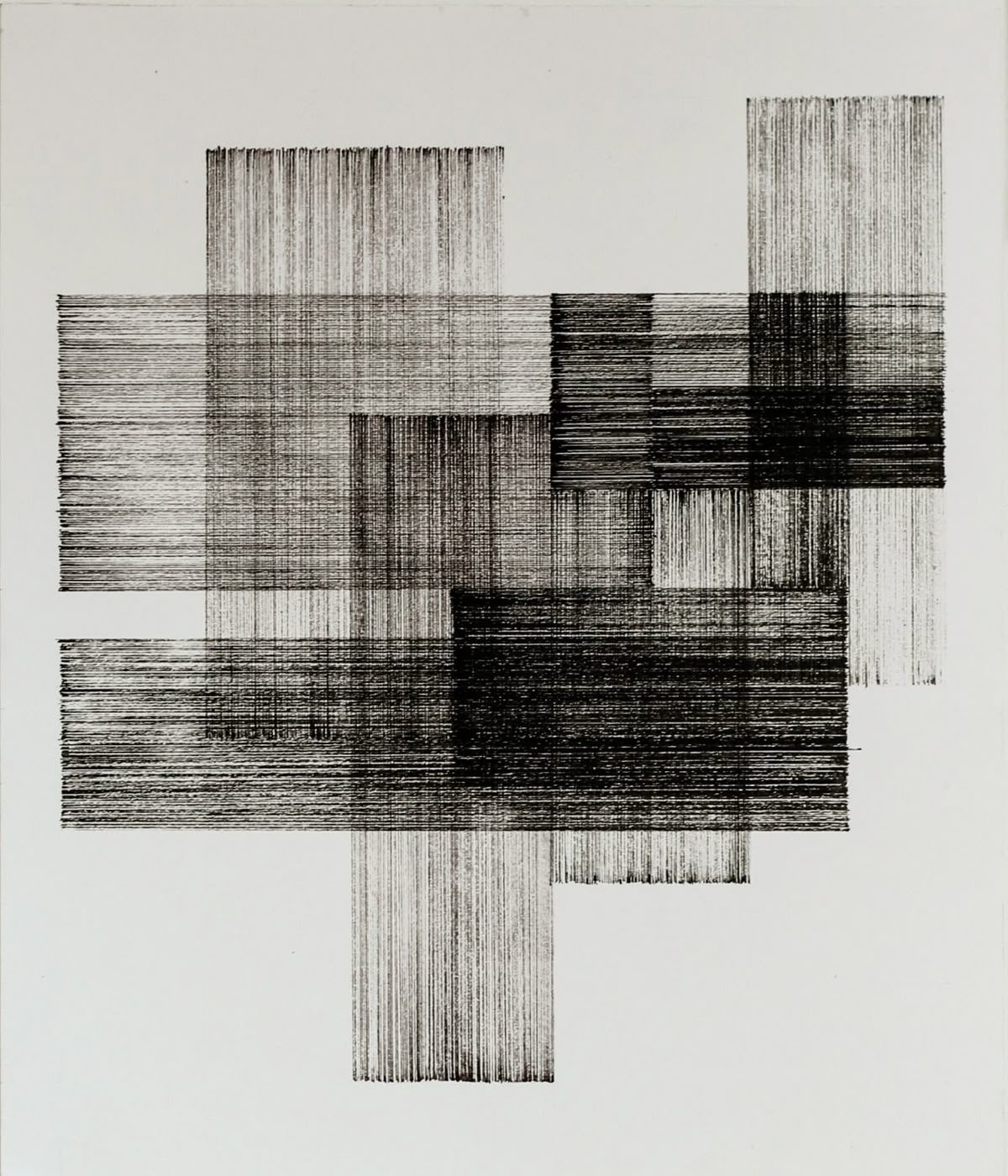
© Novaradio