Geografie del potere nella rivoluzione digitale
Into the Black Box
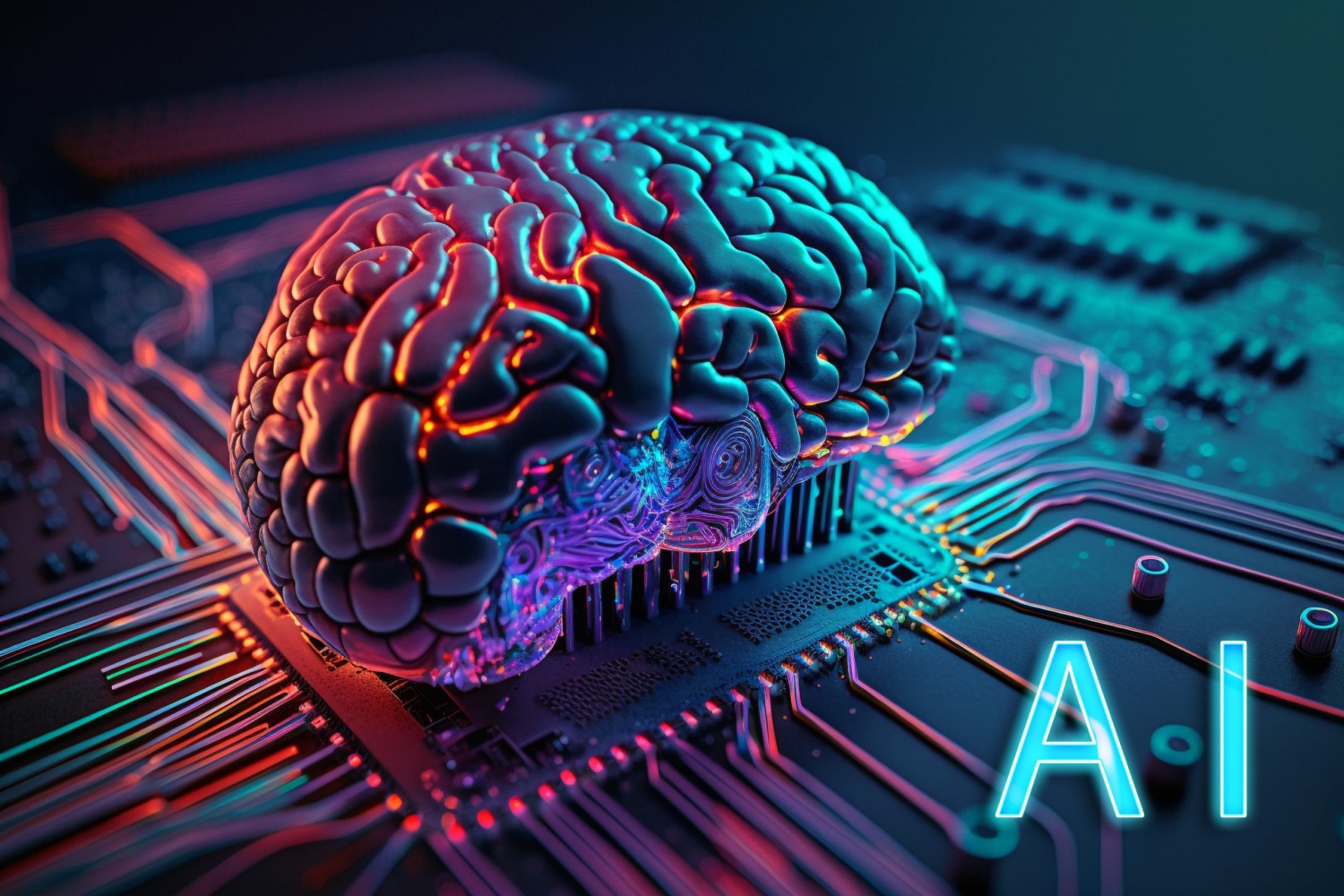
Dal Duemila ad oggi, almeno, il digitale si è andato sempre più a sostanziare come “luogo” effettivo di produzione e riproduzione delle nostre vite. Che caratteristiche inedite vi possiamo cogliere dopo il grande exploit sia di innovazione tecnologica, sia di utilizzo quotidiano, che abbiamo registrato socialmente dalla pandemia in poi?
Proverò a dare una prospettiva necessariamente parziale: uno spaccato di ciò che mi sembra di aver osservato in questi anni, anche basandomi sulla letteratura scientifica corrente e sulle numerose analisi che si sono moltiplicate con l’esplosione editoriale e di ricerca sull’argomento degli ultimi anni. È vero che le tendenze che vediamo all’opera oggi sono almeno ventennali. Siamo infatti all’interno di un ciclo iniziato intorno al 2004-2005, con una prima cesura a metà degli anni 2010, tra il 2015 e il 2016, segnata da eventi come Brexit e la prima elezione di Trump. Già allora si intravedevano elementi che oggi sono diventati strutturali: la nascita di piattaforme come Airbnb e Uber e l’avvio di una tendenza che si è poi consolidata. A partire dal 2020, a mio avviso, si è verificata un’accelerazione del processo di piattaformizzazione. La piattaforma si è imposta come modello organizzativo trasversale, sia nel pubblico che nel privato. Lo abbiamo visto soprattutto dal punto di vista statale, per esempio con il PNRR in Italia. Tutto il servizio pubblico – scuola, università, pensioni, lavoro – si è “piattaformizzato”. Fino al 2015 ci trovavamo in una fase in cui le piattaforme di social media, quelle che potremmo definire “tecnoliberali”, si presentavano come promotrici di valori quali libertà, apertura, connessione e sull’uso della tecnologia come motore di avanzamento democratico. Ma già dal 2013, con lo scandalo NSA, e poi dal 2015 con Cambridge Analytica, è diventato evidente che queste piattaforme erano suscettibili di manipolazione e potevano essere strumenti di sorveglianza. Meno discussi, ma cruciali, sono stati episodi come quello che ha fatto si che l’uso di Facebook facilitasse e amplificasse la violenza contro la minoranza musulmana Rohyngi in Myanmar nel 2015 nella più totale incuria da parte della piattaforma stessa. Questo episodio insieme ad altri è stato raccontato da una ex dipendente di Facebook in quegli anni, Sarah Wynn-Williams in un libro, Careless People, che suggerisco di leggere.
Da allora è iniziata una pressione crescente sulle piattaforme di social media in particolare, ma anche motori di ricerca, culminata nel 2020-2021, quando è stato chiesto loro di intervenire sulla comunicazione pubblica – controllando la circolazione di informazioni relative al Covid e ai vaccini. Uno dei grandi temi degli ultimi anni che si è amplificato con il Covid, in fatti, è stato il rapporto fra piattaforme e Stati: queste aziende non hanno mai gradito essere chiamate a esercitare funzioni governamentali, cioè controllare ciò che accade sulle piattaforme per motivi politici e non puramente commerciali. Secondo me, è questo il contesto da cui emerge la svolta politica e culturale di questi anni. La Silicon Valley, fino al 2020 circa, si considerava tendenzialmente “democratica” o liberal; ma la crisi del rapporto fra piattaforme, Stati e opinione pubblica ha aperto un conflitto che li ha portati ad avvicinarsi ai Repubblicani e specialmente a Trump.
Gli studi sull’uso delle piattaforme da parte della destra e dell’estrema destra (neofascisti inclusi) mostrano come, a differenza degli utenti di sinistra o liberali, si siano create “camere dell’eco” o “di riverberazione” o echo chambers in cui questi gruppi si sono radicalizzati. Come sostengono gli autori del volume Network Propaganda: Manipulation, Disinformation and Radicalization in American Politics, uscito nel 2018 per la Oxford University Press, è più corretto parlare di radicalizzazione delle destre piuttosto che di polarizzazione. La radicalizzazione, collegata alle proteste anti-vaccino e al trumpismo, ha dato origine a quella che gli autori del volume (Yochai Benkler, Robert Faris e Hal Roberts) hanno definito una nuova forma di propaganda di destra, basata sull’uso sistematico delle fake news. Come scrive Benkler: «abbiamo iniziato volendo essere imparziali, ma la fake news di sinistra non esiste». La disinformazione, sostiene, è uno strumento strutturale dei movimenti di estrema destra. E Trump, come sappiamo, ha fatto un uso esplicito e strategico della menzogna come arma politica. Il sociologo afroamericano W.E.B. Du Bois definiva già a suo tempo le forme di potere coloniale come basate su «menzogna e forza bruta». Si parla spesso di polarizzazione, ma io credo che ciò che vediamo oggi sia piuttosto una biforcazione: una radicalizzazione della destra, con tratti messianici e religiosi (come negli Stati Uniti o in India), contrapposta a forme di opposizione abolizionista anti-razzista, anti-coloniale, anti-capitalista, ecologista e trans-femminista che propongono visioni del mondo opposte. Riprendendo studi femministi come Backlash (1991) di Susan Faludi, Empowered: Popular Feminism and Popular Mysoginy (2018) di Sarah Banet-Weiser e Microfascismo di Jack Bratich (uscito recentemente in traduzione italiana per Castelvecchi) possiamo leggere questa dinamica come un meccanismo di risposta e reazione: da un lato la presa di parola delle soggettività subalterne online, dall’altro la reazione dei gruppi che si percepiscono minacciati. Non è una dialettica, ma una vera biforcazione fra due modelli di società. Da una parte, la restaurazione di un ordine patriarcale, razzista, coloniale, capitalista e maschile che si esprime attorno a valori quale Dio (monoteismo, autorità del libro sacro), Patria (Stato), Famiglia (tradizionale), e Mercato (capitalista) ancorati solidamente ad un suprematismo bianco o comunque modellato su di esso. Dall’altra quella che Ruth Wilson Gilmore in un testo come Abolition Geography (2022) chiama società politica opposizionale, orientata verso l’abolizione delle strutture di potere esistente e la loro trasformazione in chiave liberatoria. Questa biforcazione permea il nuovo mercato della produzione di contenuti, che con TikTok e le piattaforme di monetizzazione ha portato alla presa di parola di soggettività finora escluse dai circuiti della comunicazione. Questa presa di parola si è intrecciata anche a un meccanismo di autosfruttamento: la messa in esposizione del privato è diventata una nuova forma di lavoro.
Passando al dibattito attualissimo sull'intelligenza artificiale, cosa emerge dal tentativo di cartografare questo nuovo strumento?
Per me l’AI è ancora un enigma. Abbiamo alcuni dati sui rapporti psicosociali con l’AI e sulle relazioni che le persone instaurano con sistemi artificiali, ma si tratta spesso di narrazioni giornalistiche che inseguono i trend del momento. Sappiamo anche che le AI non hanno memoria. E come si può costruire una relazione con qualcuno che non ha memoria? Quando i risultati di processi precedenti vengono reinseriti continuamente senza apertura all’esterno, le AI mostrano caratteristiche paragonabili a patologie neurologiche – un rapporto problematico con il tempo, la continuità e la storia. E allo stesso tempo, altri ancora (penso alla mia amica Luciana Parisi) suggeriscono che nella modalità di ragione dello strumento AI troviamo anche l’incomputabile e l’alieno.
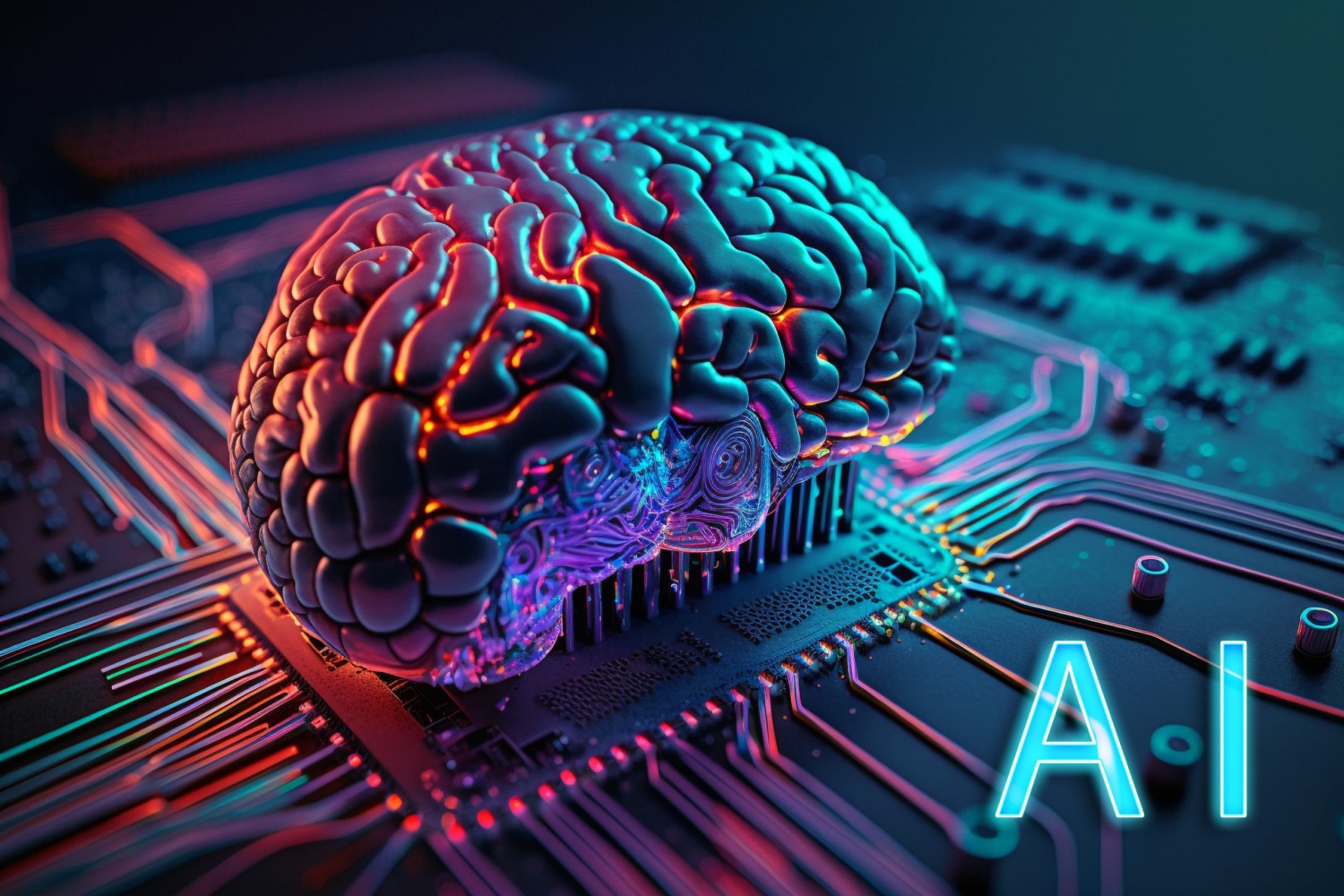

I costi ambientali della generative AI (come mostra bene Kate Crawford in un recente articolo sulla rivista online e-flux “Eating the Future: The Metabolico Logic of A.I. Slop”) è devastante, ma davvero è l’unico modello possibile dal punto di vista ecologico di intelligenza artificiale o è quello perseguito per motivi politici dai giganti americani? C’è poi la minaccia della sostituzione del lavoro umano: linguistico, comunicativo, ma anche creativo e performativo (attori, modelle, traduttori, editori…) secondo una traiettora ben documentata nel saggio di Matteo Pasquinelli Nell’occhio dell’algoritmo (2025). Non sappiamo ancora quanto siano davvero efficienti le AI, né quanto controllo e supervisione umana richiedano. Si parla anche di automazione della scrittura del codice informatico e del fatto che, probabilmente, il capitalismo userà questa transizione per sostituire lavoratori e lavoratrici con macchine, come già accaduto in altri cicli storici. Altri invece sostengono che l’automazione della produzione di software renderà possibile progettare a costi molto più contenuti applicazioni di software alternative. Oggi c’è una fortissima pressione per introdurre le AI nelle imprese e nelle pubbliche amministrazioni, accompagnata da una bolla speculativa enorme, con investimenti paragonabili ai bilanci di interi Stati. Molti studiosi ritengono che questo entusiasmo non sia giustificato dai risultati concreti.
Stante quello che abbiamo detto, nel dibattito pubblico sembra permanere una rigida dicotomia tra spazio fisico e spazio cibernetico. Ma credi sia ancora possibile pensare lo spazio fisico separato da quello digitale, o viceversa confinare il digitale a una mera “dependance” fittizia del mondo incarnato?
Sì, è un vecchio tema – forse uno dei primi emersi con la comunicazione mediata dai computer: vero e falso, realtà autentica e realtà simulata. Il fatto che questa distinzione persista va collegato al cambiamento di enfasi: oggi riguarda soprattutto la performatività dei soggetti online. Il “modello celebrity” ha prevalso: ognuno cura la propria immagine digitale come un personaggio pubblico. Di conseguenza, si è diffusa la percezione che non ci si possa fidare di ciò che si vede sui social, perché si tratta di presentazioni performative e costruite. È una dimensione pubblica di tipo teatrale. Siamo inoltre intrappolati in una contrapposizione fra un sapere “scientifico” autorevole e a tratti autoritario e le opinioni non scientifiche delle echo chambers. Durante il Covid, da un lato si invocava l’“autorità dello scienziato”, dall’altro si diffondevano complotti e teorie alternative. Oggi, secondo me, la distinzione tra reale e virtuale riflette una nostalgia per un mondo in cui gli esperti erano ascoltati e il pubblico si lasciava guidare. Ma in realtà il mondo digitale e quello analogico, pur distinti, non sono separabili. La questione fondamentale è l’interfaccia fra corpo e schermo: il punto in cui il cervello e il sistema nervoso interagiscono con il digitale – come ben sottolineava Giorgio Griziotti nel suo saggio Neurocapitalismo di qualche anno fa. Le interfacce sono progettate per sollecitare reazioni fisiologiche reali: dopamina, piacere, dolore, rabbia, gioia. Il digitale agisce sul corpo in modo concreto. Come osserva Ravi Sundaram nel suo saggio Post-Poscolonial Sensory Infrastructures (2015 e-flux) in città come Delhi o Lagos o Rio il collasso fra il mediale e il sociale è già evidente. La teorica afro-brasiliana Denise Ferreira da Silva ha scritto importanti saggi (Toward a Global Idea of Race del 2007 e più recentemente Unpayable Debt, del 2022) sulla necessità di fare saltare i pilastri epistemologici della modernità: determinazione, sequenzialità e separazione. Bisogna partire da una concezione quantistica della realtà, in cui vige l’inseparabilità e in cui l’osservatore costruisce il fenomeno e gli eventi sono intrecciati..
Buona parte del tuo lavoro indaga come pratiche di cooperazione digitale possano aprire scenari di messa in discussione complessiva del nostro presente. Quali linee di tendenza intravedi? Quali sfide e opportunità politiche per i movimenti dei prossimi anni?
Questo è qualcosa che sta già accadendo. Il peggio e il meglio coesistono nella comunicazione digitale. Dal mio punto di vista, ciò che colpisce è come gli scenari considerati opposti oggi si sovrappongano. Black Mirror è arrivato, ma anche il suo contrario. Accanto al controllo e alla profilazione, assistiamo a fenomeni di solidarietà transnazionale senza precedenti, a una capacità di aggirare la censura e di rompere i dispositivi governamentali di connessione. Come evidenziano gli studi del Riot Platform Project, il livello di proteste negli ultimi anni è paragonabile a quello degli anni Sessanta. È un periodo di effervescenza globale. È vero che questi movimenti spesso si gonfiano e si sgonfiano rapidamente, ma forse dovremmo guardare a contesti come il Sudafrica o la Palestina per comprendere come questa coesistenza di mondi opposti – il “gatto di Schrödinger” – possa collassare in un mondo più giusto e vivibile. Il futuro dipende dalla nostra capacità organizzativa e dall’intelligenza collettiva che sapremo mobilitare. Come scrive Michael Hardt in I Settanta sovversivi, le tensioni degli anni Settanta – classe, genere, razza, etnicità – continuano a segnare la politica contemporanea. Non si tratta di “politiche dell’identità”, perché la destra è quella che oggi fa identitarismo. La sfida è costruire movimenti che non riproducano rapporti di potere sistemici, ma che li attraversino e li trasformino. Uno dei concetti più fecondi oggi è quello di ricorsività: il risultato di un’azione precedente viene richiamato e incorporato in quella successiva, producendo esiti nuovi. Ecco perché non sono pessimista: credo che viviamo ancora in uno stato di sospensione, in cui mondi paralleli coesistono e la loro risoluzione resta da decidere.
